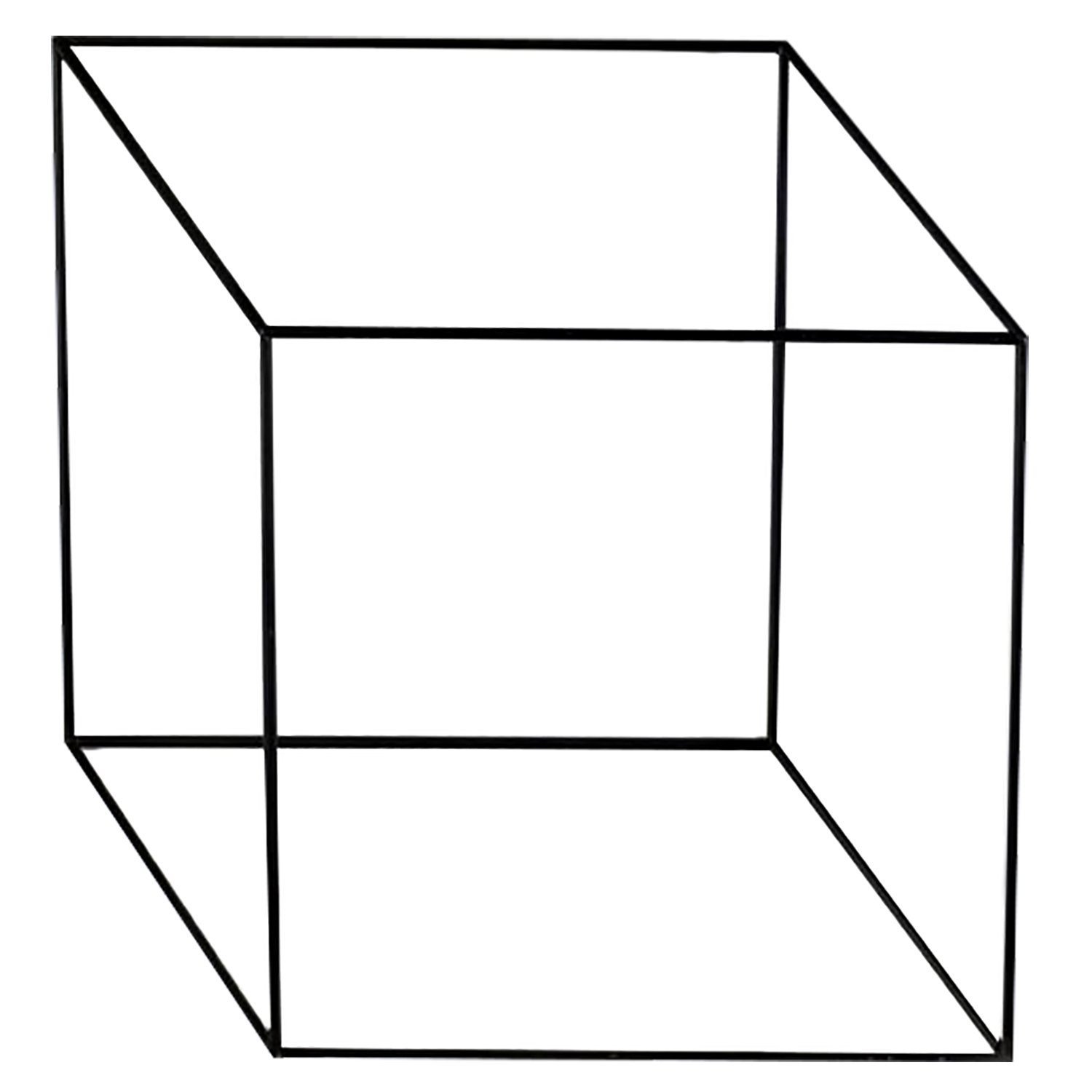comunità e artisti
al Centro Gallignano Arte
Alcune immagini (e non è retorica) riescono immediatamente a condurci in un’epoca.
Non per lieti ‘amarcord’ tutti personali, né per rimpianti di sorta; perché, invece, negli sguardi, nelle posture, nei corpi, emergono tessiture di rapporti, le cui condizioni risiedono in momenti particolari della Storia, in cui le singole, individuali, storie si incontrano, attraversando movimenti sociali, politici, culturali, e lì si attraversano.
Qui, queste tessiture sono fissate nell’attimo.
Siamo a Gallignano, frazione di Ancona, nel luglio del 1977.
Facciamo parlare i documenti: dal catalogo “Documenti 77. L’interrogazione sistematica. Frascà Minoli Scaccabarozzi” (dove questa foto fu pubblicata):

“… Del centro Gallignano fanno parte tutti i cinquecentotrentaquattro componenti della comunità. Il Centro si ripromette di effettuare una serie programmata a lunga scadenza di mostre dibattiti, conferenze, manifestazioni [… ]. Tutto per lo sviluppo culturale della comunità ma soprattutto per creare un dialogo col mondo dell’arte aperto ad ogni proposta e discussione. Il Centro Gallignano di ripromette altresì di ospitare a stretto contatto con le famiglie addirittura al proprio tavolo nelle proprie case operatori artistici e critici per un arricchimento reciproco.
Come luogo espositivo è stato concesso l’uso di una chiesa resa inagibile da varie traversie terremoti e bombardamenti che tutta la comunità ha restaurato”.
Frascà, a destra, di quinta, si volge verso una donna che abbraccia Antonio Scaccabarozzi, il cui sguardo, rivolto verso il basso, va verso un uomo disteso, che guarda in camera: lei è Lydia Megert, gallerista di Berna, che lavora molto con artisti italiani, tra cui Scaccabarozzi, ospitato nella Galerie Megert nel ‘76; lui è Rudolf Mattes, artista svizzero anch’egli in quell’anno in galleria a Berna e che nel ’77 espone al Centro Gallignano… tessiture di rapporti.
Nella foto non è presente Paolo Minoli, il terzo dei tre artisti che hanno trovato luogo nella chiesa di Gallignano e che hanno legato la propria attività in una comune tensione di ricerca, cui hanno dato il nome di “Interrogazione sistematica”, che li condurrà ad esposizioni comuni tra il 77 e il 78.
I cinque (Frascà, Scaccabarozzi, Megert, Mattes e Minoli) li troveremo, in altra foto, assieme, a Berna, poco dopo, nel settembre ‘77 alla Galerie Megert.
Gli altri?
Comunità: è la comunità di Gallignano, tra cui certamente ci sono Ivano Cafarri, di cui è animatore, con Iris.
E’ probabile vi sia Brunella Antomarini, che scrive un impegnativo contributo sul catalogo; e forse Alfio Vico, fabbro-gallerista che nel 1975 aveva aperto la Galleria del Falconiere (a Falconara, poi portata ad Ancora) dove parte delle opere di Frascà, Minoli e Scaccabarozzi erano esposte nel Luglio ‘77.
Ma ancora, affidiamoci ai documenti.
“Gubbio ‘76”, un insieme di materiali che iniziano dalle riflessioni prima e dopo l’edizione del 1975 della VIII Biennale del metallo, in previsione di quella del ’76, curata da Enrico Crispolti e documentata nel catalogo.
Negli interventi e nelle relazioni pubblicate, quelli di Frascà sono puntuali e molto critici: nei contributi di critici e artisti per l’edizione del ’76, presenta una “Comunicazione” su Gallignano.
“Operai del Cantiere Navale di Ancona, agricoltori, muratori, studenti, pensionati, lavoratrici, maestri, professori, etc.
Hanno fondato un Centro Artistico ripristinando una vecchia chiesa in disuso e bombardata. I lavori sono stati autofinanziati, eseguiti e gestiti dalla popolazione che ha restaurato l’interno e l’esterno della chiesa con le proprie mani e i propri mezzi.”
Già nel ’76 Frascà poteva realizzare una mostra personale, con tre interventi. Scrive:
“… mentre si lavorava – a porte aperte – con chi veniva a chiedere spiegazioni, a curiosare, a dire battute, anche ironiche. Si è ben presto stabilita una corrente comunicativa.
… Abbiamo ancora discusso con tutti quelli che chiedevano, abbiamo mangiato, bevuto, raccontato storie, si sono organizzati scherzi e credo per la prima volta nella mia carriera di aver avuto la sensazione gradevole che era anche il mio lavoro che li faceva stare insieme”.
Qui (e si sono già stagliate altrove le minacciose nubi degli ‘anni di piombo’) gli anni Settanta portano ancora il segno delle istanze collettive, del bisogno di conoscenza, di formazione di rapporti e trasformazione di quelli sociali, ove l’arte (e con essa la critica) non può essere estranea alla società, che, da ‘popolo’ o ‘massa’, si concreta in città, quartiere, scuola, fabbrica.
Non stupisce, allora che alla Biennale di Venezia del ’76 “Ambiente Partecipazione Strutture culturali” (che si era aperta poco prima della mostra di Frascà a Gallignano) la sezione italiana, curata da Crispolti, sia intitolata “Ambiente come sociale”. Scrive Crispolti: “per l’operatore culturale visivo (e non) la più attuale nozione di ambiente è certamente quella d’ambiente come sociale, urbano o extra-urbano. Il sociale infatti – con la sua fortissima domanda di massa – rappresenta oggi indubbiamente una nuova area di esperienza per l’operatore culturale”.
Sulla rivista Spazioarte, nel numero del gennaio-marzo del 1977 (di poco precedente la foto che presentiamo), dedicata al “ruolo dell’operatore visivo”, ancora Crispolti afferma: “La prospettiva credo sia proprio quella di studiare, di inventare delle strategie di comunicazione con questa realtà che è intorno a noi, una realtà socioculturale che pone una precisa domanda di partecipazione”.
Ciò che porta tre artisti affermati qui, in una piccola frazione delle Marche, a verificare le proprie ricerche e sperimentazioni, ad ascoltare, discutere, a “raccontare storie”: in fondo, la Storia dell’arte, non è arte di raccontare?

Diramazioni, in itinere
… agenda 19/7/77: “da Tonino e Regina”, “Enzo e Brunella”
… “Narciso si cerca e e si perde”: il testo di Brunella Antomarini
… alla Galerie Megert, Berna